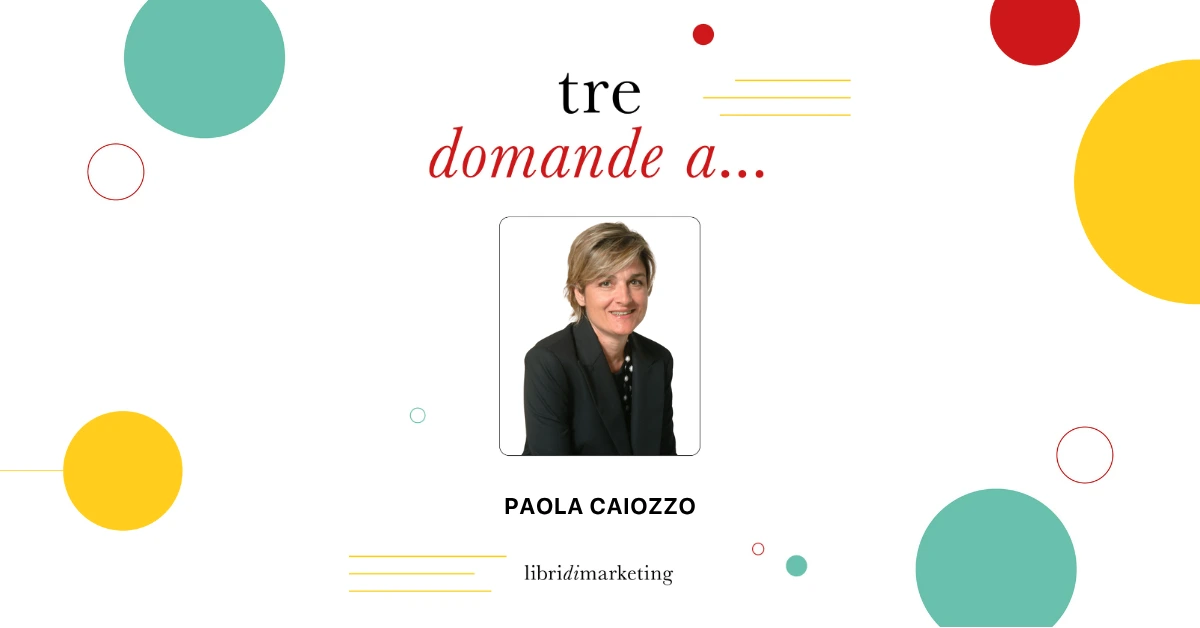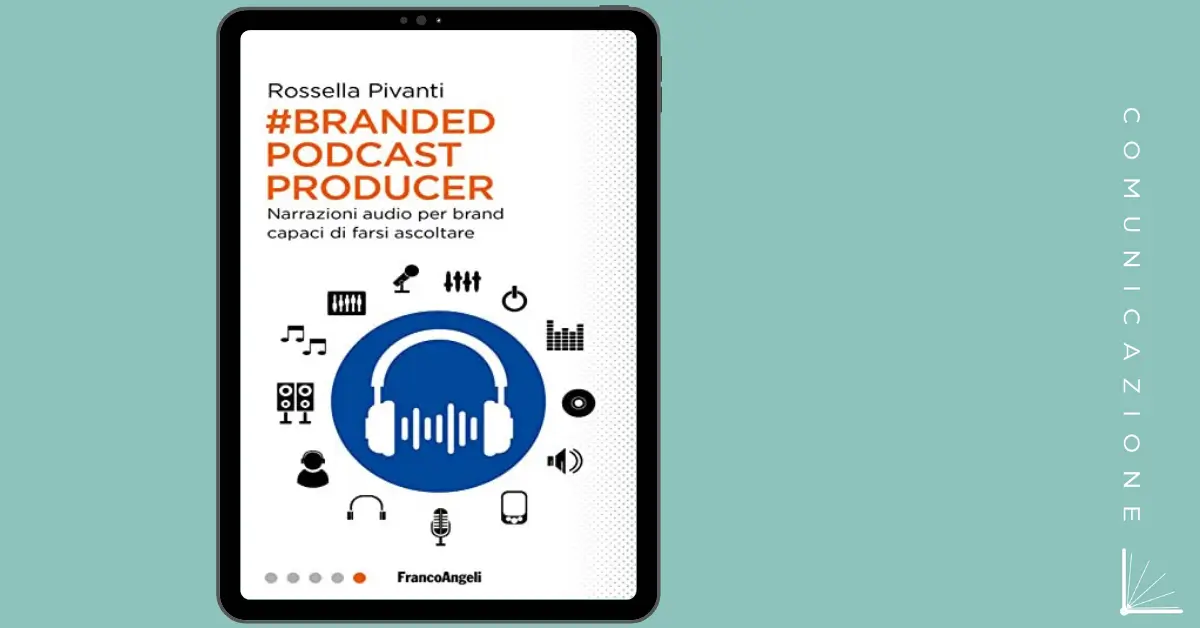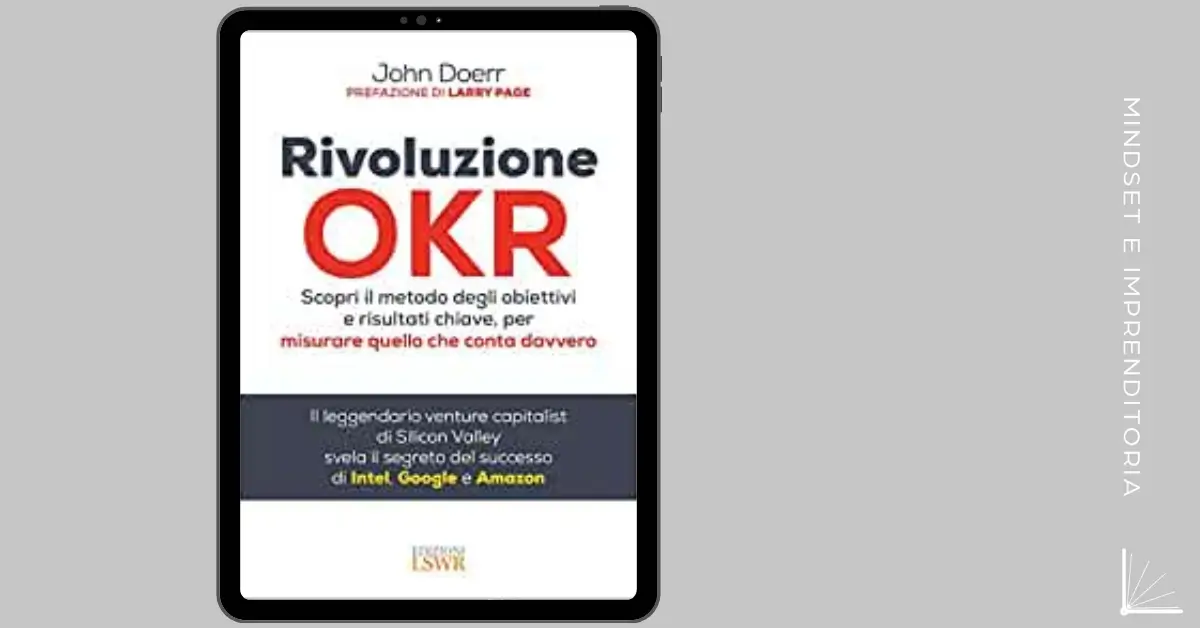Paola Caiozzo è una delle voci più autorevoli in Italia quando si parla di eccellenza commerciale, comportamento organizzativo e strategie di vendita.
Senior Lecturer presso SDA Bocconi School of Management, vanta una lunga esperienza nella formazione manageriale per aziende italiane e internazionali, con un focus specifico su Leadership, Comportamento organizzativo in ambito Sales e Sales Transformation . È co-fondatrice e coordinatrice del Commercial Excellence Lab, l’unico centro italiano focalizzato sull’eccellenza in ambito commerciale, frutto della collaborazione tra mondo accademico e imprese, punto di riferimento per la ricerca applicata in questo ambito.
La sua attività si muove al confine tra ricerca accademica e impatto sul campo, con progetti che analizzano le sfide della digitalizzazione sui processi e sulle reti commerciali, le sfide per il sales management in ottica della Commercial Excellence, l’evoluzione dei ruoli di vendita ed il loro reskill o upskill coerenti alle richieste dal mercato.
Autrice di numerose pubblicazioni, l’ultima uscita nel 2025 “Commercial excellence: la scienza dietro l’arte dell’eccellenza commerciale”, è anche speaker a eventi internazionali, affiancando al rigore scientifico una profonda attenzione alle dinamiche reali delle imprese.
A Settembre 2025 sarà tra i protagonisti del Sales Forum di Milano, il principale evento italiano dedicato all’universo delle vendite, dove porterà la sua visione su come costruire modelli commerciali efficaci, sostenibili e orientati al futuro.
Abbiamo avuto il piacere di intervistarla. Ecco cosa le abbiamo chiesto.
In un settore ancora fortemente maschile come quello delle vendite, qual è oggi lo spazio reale per una leadership femminile riconosciuta, ascoltata e valorizzata? Quali barriere culturali e strutturali persistono, e quali leve formative – sia individuali che organizzative – ritiene fondamentali per colmare questo divario e favorire un reale cambiamento?
Oggi, lo spazio per una leadership femminile riconosciuta e valorizzata nel settore delle vendite è in crescita, seppur lentamente, ma ancora non pienamente realizzato. Una nostra ricerca del 2023 su un campione di 383 giovani talenti dimostra che proprio le donne (il 41,4% del campione) sono maggiormente interessate a intraprendere una carriera nelle vendite rispetto agli uomini (25%). Ma non solo: il 27% del campione femminile dichiara proprio la volontà di lavorare nelle vendite. In un momento storico dove l’attraction di talenti nelle professioni commerciali è una delle prime emergenze che stanno affrontando le aziende in tutti i settori, questa sembra un’ottima notizia. Tuttavia permangono ancora delle barriere culturali, spesso radicate in stereotipi di genere, che associano le vendite a tratti tradizionalmente maschili come l’aggressività e la competitività. Questo può portare pregiudizi inconsci. Ad esempio, le donne potrebbero essere considerate meno adatte a causa di una presunta scarsa assertività o ad una presunta carenza di capacità negoziale. Nei fatti, tali stereotipi sono antiquati e non allineati con l’evoluzione attuale delle vendite.
Già nel 1995 studi pionieristici in questo campo (Siguaw & Honeycutt, Jr.) hanno suggerito che le donne sono più propense ad agire come consulenti per la risoluzione dei problemi e ad assistere i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi, piuttosto che puntare solo alla chiusura della vendita. Altri studi evidenziano che le donne venditrici sono spesso più empatiche e praticano un ascolto attivo, costruendo relazioni fiduciarie forti e alta personalizzazione. Questo si traduce in relazioni più forti, aumento delle vendite e una maggiore coerenza con la vendita consulenziale.
Un problema per le donne è l’esistenza di culture aziendali ancora improntate a modelli maschili, con orari di lavoro rigidi e aspettative di disponibilità totale del venditore; condizioni che possono non allinearsi con le esigenze o le preferenze delle donne. Inoltre, la scarsità di donne in posizioni dirigenziali senior nelle vendite può rappresentare un limite alla possibilità, per le giovani professioniste, di avere figure a cui ispirarsi e da cui imparare.
Per sbloccare il potenziale della leadership femminile nel settore delle vendite è necessario un approccio olistico che agisca sia sulla cultura aziendale, scardinando stereotipi e pregiudizi, sia sulle strutture e nei sistemi organizzativi, creando un ambiente più equo e inclusivo.
L’adozione di politiche di Diversity, Equity & Inclusion per l’adeguamento dei sistemi organizzativi potrebbe far molto. Potrebbe, ad esempio:
- promuovere e implementare politiche di flessibilità oraria, smart working, congedi parentali paritari e supporto alla genitorialità, che siano realmente accessibili e incoraggianti;
- stabilire obiettivi chiari e misurabili per aumentare la rappresentanza femminile a tutti i livelli, in particolare nelle posizioni di leadership, e monitorarne i progressi;
- promuovere una cultura aziendale che valorizzi il feedback costruttivo, riconosca i meriti indipendentemente dal genere e celebri i successi delle donne leader.
Anche la formazione ha giocato e gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, a livello organizzativo, può dare un contributo sostanziale ad esempio attraverso programmi di:
- mentoring e sponsorship interni: creando percorsi strutturati in cui leader senior, anche uomini, sponsorizzino e guidino le donne con alto potenziale, offrendo loro visibilità e opportunità;
- leadership al femminile: implementando percorsi di sviluppo della leadership specificamente pensati per le donne, che affrontino le barriere di genere e valorizzino i punti di forza femminili.
L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il modo in cui le aziende approcciano il cliente e gestiscono il ciclo di vendita. Dal suo punto di vista, l’AI è oggi un alleato strategico o rischia di spersonalizzare e automatizzare eccessivamente il processo commerciale? In parallelo, come stanno evolvendo le competenze richieste ai venditori e ai team commerciali? E quali saranno, secondo lei, le skill davvero determinanti nei prossimi 5-10 anni?
L’Intelligenza Artificiale (AI) sta indubbiamente rivoluzionando il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e gestiscono l’intero ciclo di vendita.
Il rischio di spersonalizzare e automatizzare eccessivamente il processo commerciale esiste, se non si considera l’AI come uno strumento che potenzia l’azione commerciale dei venditori.
L’AI permette di analizzare enormi quantità di dati in tempo reale, offrendo una comprensione approfondita del comportamento del cliente, delle sue esigenze e delle sue preferenze. Come Commercial Excellence Lab stiamo studiando la sua influenza e i suoi ambiti di applicazione sia sulle fasi del processo di vendita, sia sulle decisioni e sulle leve di Sales Management.
Ad esempio per:
- la lead generation e qualificazione dei prospect: gli algoritmi possono identificare i potenziali clienti con maggiore probabilità di conversione, ottimizzando l’allocazione delle risorse del team di vendita;
- la personalizzazione su ampia scala: l’AI consente di offrire esperienze cliente altamente personalizzate, suggerendo prodotti o servizi pertinenti e comunicazioni su misura, che altrimenti sarebbero impossibili da gestire manualmente;
- l’automazione di attività ripetitive: compiti come l’inserimento dati, la programmazione di appuntamenti o il follow-up iniziale possono essere automatizzati, liberando tempo prezioso per i venditori;
- la previsione delle vendite e l’ottimizzazione delle strategie: l’AI può prevedere le tendenze future, aiutando le aziende a calibrare le loro strategie commerciali e a identificare nuove opportunità.
Come è evidente nel nostro ultimo volume, La Commercial Excellence, l’introduzione massiva della tecnologia, oltre a vari altri macro-cambiamenti, sta ridefinendo le competenze richieste ai venditori e ai team commerciali.
Inoltre, in ragione di un processo commerciale sempre più sofisticato, specialmente nel B2B, l’attività commerciale è sempre più un’attività che richiede, oltre alle tradizionali competenze relazionali, anche ampie competenze tecniche, sia di prodotto, sia di gestione del business e non solo.
Le competenze richieste stanno evolvendo verso un mix che richiede anche forti competenze analitiche:
- capacità di interpretazione dei dati: i venditori devono essere in grado di comprendere e interpretare i dati disponibili, trasformandoli in insight azionabili per il cliente;
- adattabilità e flessibilità: il panorama delle vendite è in continua evoluzione; la capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento di ruolo, ai nuovi strumenti, metodologie e aspettative dei clienti è fondamentale;
- problem solving complesso: l’automazione delle attività più semplici può consentire al venditore di concentrarsi su sfide più complesse, per diventare un risolutore di problemi per il cliente;
- competenze digitali e tecnologiche: su queste i venditori hanno un cammino lungo, a volte frastagliato, per sentirsi a loro agio con le nuove tecnologie che nei fatti modificano molte delle attività tradizionali e la loro funzione di produzione.
Nei prossimi 5-10 anni, le skill davvero determinanti per i venditori e i team commerciali saranno quelle che l’AI non può replicare ma che, al contrario, l’AI può amplificare.
Per fare qualche esempio:
- intelligenza emotiva ed empatia: la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri, creando connessioni autentiche. Per ora l’AI può fornire dati sui comportamenti, ma la comprensione profonda delle motivazioni e delle paure umane sembra rimanere un dominio prettamente umano cruciale per costruire relazioni di fiducia durature;
- pensiero critico e strategico: l’AI potrà fornirà risposte, scenari e suggerimenti, ma sarà il venditore umano a doverle valutare criticamente, contestualizzarle e integrarle in una strategia di vendita più ampia, identificando le migliori opportunità;
- creatività e innovazione: la capacità di pensare fuori dagli schemi, proporre soluzioni originali ai problemi dei clienti e innovare l’approccio alla vendita. L’AI può generare molteplici opzioni, ma la scintilla dell’innovazione e la capacità di visione appartengono solo all’essere umano;
- capacità di narrazione (storytelling): in un mondo ricco di dati, la capacità di trasformare informazioni complesse in narrazioni coinvolgenti che risuonino con le emozioni e le esigenze del cliente sarà una skill distintiva. Non basta presentare i fatti, bisogna saperli raccontare in modo persuasivo;
- collaborazione e cross-functionality: i team di vendita saranno sempre più integrati con altre funzioni aziendali (marketing, servizio clienti, sviluppo prodotto). La capacità di collaborare efficacemente con diverse figure professionali e di comprendere le dinamiche interfunzionali sarà essenziale.
In sintesi, le tecnologie e l’AI possono essere degli amplificatori delle capacità umane nelle vendite. Ma, a mio parere, il ruolo dell’AI non è oggi (e mi auguro non sarà mai) quello di sostituire la componente umana. Sarà invece utile per liberarla dalle mansioni più routinarie e meno interessanti per permettergli di concentrarsi su ciò che fa la differenza: la relazione umana.
Nel suo lavoro lei esplora spesso il legame tra comportamento organizzativo e performance commerciali. In che misura la cultura aziendale incide concretamente sull’efficacia delle reti vendita? E guardando al panorama italiano, qual è a suo avviso l’errore più diffuso – o forse più sottovalutato – che le imprese commettono quando costruiscono (o correggono) la propria strategia commerciale?
Una cultura ed un’organizzazione aziendali forti, orientate ai valori giusti, possono trasformare radicalmente il modo in cui i venditori operano e, di conseguenza, i risultati che ottengono.
Entrambe, infatti, concorrono a creare le giuste condizioni per incidere su:
- motivazione ed engagement: valorizzare il venditore, riconoscere i suoi sforzi, offrire opportunità di crescita e promuovere un ambiente di lavoro positivo; aumentando intrinsecamente la motivazione e l’engagement. I venditori motivati sono più proattivi, resilienti di fronte ai “no” e determinati a raggiungere gli obiettivi;
- collaborazione interna: incoraggiare la collaborazione tra team di vendita; tra vendite, marketing, customer service e produzione, ottimizza i processi commerciali. I venditori possono così avere accesso a informazioni più complete e possono dare un supporto più rapido ai clienti attraverso la capacità di offrire soluzioni più integrate che migliorano l’efficacia complessiva;
- orientamento al cliente: una cultura fortemente “customer-centric” spinge i venditori a non limitarsi alla transazione, ma a costruire relazioni di lungo termine con i clienti; a comprendere profondamente le loro esigenze e a proporre soluzioni danno loro valore. Questo si traduce in maggiore fedeltà dei clienti, possibilità di up-selling e di cross-selling;
- apprendimento e sviluppo: investire nella formazione continua e nello sviluppo delle competenze dei venditori crea una forza vendita agile, aggiornata sulle ultime tecniche e tecnologie, pronta ad affrontare le sfide del mercato;
- gestione dell’errore e resilienza: in un settore come le vendite, il “no” è all’ordine del giorno. Una cultura che non demonizza l’errore, ma lo vede come un’opportunità di apprendimento favorisce la resilienza e la capacità dei venditori di ripartire con maggiore determinazione;
- allineamento con la strategia aziendale: quando la cultura è allineata con la strategia aziendale e con quella commerciale, tutti remano nella stessa direzione. I venditori comprendono la visione complessiva, gli obiettivi a lungo termine e si sentono parte integrante del successo aziendale, il che porta a una maggiore coesione e performance.
Purtroppo, però, devo dire che su questo fronte c’è ancora molto da fare.
Parlando invece dell’errore più diffuso (o sottovalutato) che le imprese fanno nel delineare nuove strategie commerciali è la disconnessione tra la strategia top-down e la sua effettiva implementazione sul campo, che spesso è caratterizzata da una sottovalutazione dell’importanza della cultura aziendale, da una carenza di adeguamento dell’assetto organizzativo e dei suoi processi alla mutata strategia e dello scarso utilizzo mirato della leva formazione.
Mi spiego meglio. Molte aziende italiane sono eccellenti nella definizione della strategia commerciale, ma peccano nell’esecuzione.
Il problema non è la mancanza di un piano, ma la difficoltà di tradurre quel piano in comportamenti quotidiani sostenibili dalla forza vendita.
Questo si manifesta in diversi modi:
- focalizzazione eccessiva sul “cosa” e insufficiente sul “come”: si definiscono obiettivi di vendita ambiziosi (il “cosa”), ma si presta meno attenzione al “come” raggiungerli, ovvero all’adeguamento dei processi commerciali e/o di sales performance management agli strumenti e, soprattutto, alle competenze e alla mentalità dei venditori;
- mancanza di allineamento: spesso si introducono cambiamenti legati all’introduzione di nuove metodologie e nuove tecnologie (es. CRM e AI), ma non si preparano adeguatamente le reti commerciale e l’organizzazione ad accoglierle. Tra i processi più sottovalutati ci sono quelli di comunicazione interna: ad esempio lo spiegare la “reason why”, il mostrare la consapevolezza di come il cambiamento modifica il lavoro dei commerciali, il ridefinire obiettivi e aspettative coerenti ai tempi del cambiamento sono tra gli elementi che più impattano sulla reazione ad esso, nutrendo le resistenze, come evidente dalle molteplici ricerche condotte in questi anni;
- sottovalutazione della formazione continua e dell’upskilling: si assume che i venditori, una volta acquisite le basi, siano totalmente autonomi. In un mercato in rapida evoluzione, dove il cliente è sempre più informato e le tecnologie cambiano rapidamente, le funzioni di produzione del venditore e quindi le sue attività e il suo ruolo evolvono, richiedendo l’apprendimento di nuove skills o l’aggiornamento delle competenze storiche maturate sul campo. Senza un investimento costante e mirato in una formazione coerente ai cambiamenti proposti si otterrà una forza vendita stanca, obsoleta e meno efficace;
- mancanza di riconoscimento e valorizzazione non solo economica: sebbene gli incentivi economici siano importanti, molte aziende sottovalutano che, in uno scenario di cambiamento continuo, l’impatto dei riconoscimenti non economici sugli aspetti di motivazione non monetaria (apprezzamento, opportunità di sviluppo, confronto, significato del lavoro, ecc.) diventa determinante nel motivare, trattenere i talenti di vendita e sostenere la performance.
In sintesi, l’errore non è tanto nella strategia in sé, quanto nell’incapacità di creare un ecosistema aziendale e una cultura che supportino quella strategia, abilitando i venditori a performare al massimo delle loro capacità in un contesto in costante cambiamento.