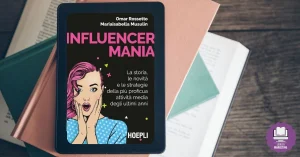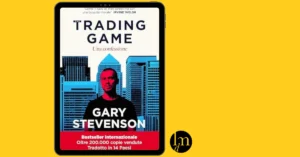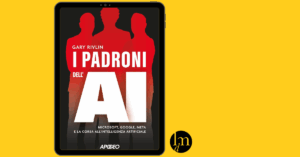Think like a dev è un manualetto che si legge in un giorno. Se anche tu divori libri come se fossero focacce genovesi, ti basteranno poche ore di lettura intensa da trascorrere insieme ad Andrea Lissandrin e Lorenzo Farinelli per comprendere il significato di pensiero computazionale.
L’obiettivo che gli autori si sono posti con la scrittura di questo manuale è ambizioso: migliorare la cultura imprenditoriale e digitale del nostro Paese. Soprattutto, ottimizzare il dialogo e la comunicazione “dei desiderata tra professionisti con background diverso, per esempio tra decision maker e sviluppatori”.
Come ha detto Patrizio Bianchi – ex rettore dell’Università di Ferrara – “L’Italia è sempre ai primi posti quando si tratta di fare ricerca e sperimentazione, ma non applichiamo e non rendiamo utile al collettivo gli studi e le prove”. Manca un passaggio.
Ci perdiamo tra riunioni infinite, richieste impossibili, tempistiche surreali senza analizzare, osservare, ragionare, trovare una soluzione condivisa.
Think like a dev è uno strumento di orientamento da utilizzare all’interno delle imprese per rendere fluidi i processi, migliorare la comprensione tra le persone coinvolte in un progetto e ricordare che “dietro a ogni bit c’è sempre un cuore pulsante e una mente che pensa”.
Gli autori di Think like a dev
Dopo l’interessante e trasparente prefazione del libro curata da Luca Cipriani, gli autori si presentano con uno scambio di battute simpatico e informale: si rivolgono al pubblico con un Ciao! diretto e semplice, e con un TU colloquiale che, purtroppo, perdiamo all’interno del manuale perché si trasforma in una seconda persona plurale.
Andrea Lissandrin è un consulente informatico e un imprenditore. Amministratore dell’azienda Synextya, una società di sviluppo software (appunto), è un appassionato di informatica e tecnologia.
Lorenzo Farinelli, socio di Andrea, è un esperto di informatica, sviluppo back-end e architettura software. Due che mangiano pane e codice a colazione, per dire.
Il libro è arricchito da quattro contributi di valore:
- Simone Severini, tecnologo e professore ordinario di Fisica dell’Informazione alla University College London presenta il pensiero computazionale come filosofia di vita;
- Antonio Civita, uno dei massimi esperti di OKR in Italia, aiuta a comprendere come evitare i contrasti in azienda con l’uso degli Objectives and Key Results;
- Mirko Campari, docente e programmatore specializzato nel paradigma dell’OOP, racconta come sviluppare una sana sincerità computazionale;
- Matteo Aliotta, esperto di Digital e co-fondatore di LTV, esprime il suo parere sul rapporto tra manager e sviluppatori.
Dalle parole di questi professionisti comprendiamo che “Guardando al futuro, diventa sempre più evidente che la capacità di comunicare con chiarezza e precisione non sarà solo un vantaggio competitivo, ma una necessità imprescindibile”.
Che cos’è il pensiero computazionale
Ora, ho faticato a capirlo. Mea culpa, non ho una mente che si presta con facilità all’informatica, al calcolo, al codice.
Una prima spiegazione efficace e sintetica la propone Luca Cipriani nella sua prefazione: “In questo scenario, il pensiero computazionale – con la sua enfasi su risoluzione metodica dei problemi, riduzione dell’ambiguità e approccio scientifico – diventerà una competenza fondamentale per tutte le persone e non solo per chi programma”.
Gli autori per darne una definizione impiegano qualche pagina. Iniziano con un aneddoto (un incontro tra due developer alla macchinetta del caffè, sembra quasi una barzelletta), continuano con esempi concreti tratti dalla loro quotidianità (nei quali ci rispecchiamo con facilità), propongono un video virale che girava qualche tempo fa (trovi il QR Code per scaricarlo), usano la tecnica del ‘immaginate che…’, della visualizzazione, per semplificare alcuni passaggi, chiariscono la differenza tra pensiero computazionale e tecnico.
Dopo una trentina di pagine, finalmente, arriviamo alla sua definizione definitiva: “A questo punto possiamo permetterci di definirlo come una sistematizzazione del pensiero. O come una vera e propria problem solving attitude che prende forma prima ancora che il problema si verifichi. Un problem solving che coinvolge rigore e metodo insieme al supporto di macchine per semplificare lavori che non ha più senso svolgere meccanicamente”.
Nel libro gli autori esprimono con chiarezza il loro punto di vista sul concetto di Human Prompt, un termine “provocatorio e illuminante” per sottolineare l’importanza del pensiero e dell’agire umano in un contesto dominato dalle macchine e dalle intelligenze artificiali.
Dietro a ogni progetto per realizzare un software ci sono più menti che ragionano, pensano, cercano soluzioni, si confrontano.
Menti che usano il pensiero computazionale per spezzettare un problema grande in piccoli tasselli, risolverlo, presentare un progetto funzionale e comunicarlo con un linguaggio comprensibile a un pubblico eterogeneo.
La struttura e l’approccio di Think like a dev
Il manuale ha una struttura elementare e lineare: quattro capitoli, un contributo per capitolo. La maggior parte del libro è scritta da Andrea; Lorenzo compare nei box dedicati alle “pillole di competenza digitale” sparsi qua e la nel testo, che spiegano alcuni termini informatici ai non addetti al settore e donano qualche consiglio pratico.
L’approccio degli autori è “pragmatico e diretto”, come spiega bene Cipriani nella prefazione: nel libro troviamo esempi concreti tratti dall’esperienza diretta degli autori che rendono la narrazione umana e calano lettrici e lettori in una realtà quotidiana, reale, autentica. Terra a terra.
La scrittura è molto semplice, lo stile informale, ironico, colloquiale, chiacchierato (forse in alcuni passaggi anche troppo, ma riflette l’approccio degli autori), farcito con le classiche espressioni come “Secondo me, nella mia idea, in questo modo, a questo punto, quindi…”.
Nel testo sono presenti diverse domande che gli autori utilizzano per coinvolgere il pubblico e chiarire i concetti. Il linguaggio è essenziale, sobrio, stringato.
Nel complesso, è un libro di facile lettura, poco impegnativo, da sfogliare in treno o in metro tra uno spostamento e l’altro.
Utilissime le ultime pagine del libro, nelle quali Lorenzo offre con praticità e chiarezza un’analisi delle figure chiave che collaborano alla realizzazione di un software e propone alcune regole per gestire con efficienza un team di developer.

Think like a dev è un libriccino che si rivolge “… a chi quotidianamente affronta idee di business o miglioramenti interni all’azienda e a chi guarda alla digitalizzazione con un occhio migliorativo”.
Non solo. “Che siate manager curiosi di comprendere meglio il mondo del software, tecnici desiderosi di migliorare la vostra capacità di comunicare il valore delle vostre soluzioni o professionisti interessati a sviluppare un pensiero strutturato, troverete in queste pagine spunti pratici e preziosi”, dice Cipriani.
Senza dubbio utile agli sviluppatori che desiderano avere qualche suggerimento per gestire un team di sviluppo software con efficacia, può aiutare anche titolari, manager, imprenditrici e imprenditori a comprendere quali sono le implicazioni del lavoro dello sviluppatore (uso il maschile perché gli autori sono due uomini eh, ma vale anche per le sviluppatrici). E perché, per esempio, sono necessarie molte ore di lavoro prima di realizzare un’applicazione che funzioni o determinare il flusso di un e-commerce.
Gli argomenti trattati dagli autori – il pensiero computazionale e il concetto di human prompt – sono interessanti. Forse (sottolineo, forse) gli autori avrebbero potuto argomentare e approfondire alcuni passaggi per arricchire il manuale e dare forza al contenuto.
Un capitolo in più, un passaggio strutturato con maggiore enfasi, un caso studio per dare corposità alla narrazione, un linguaggio più ricco per valorizzare il manuale.
A prescindere da questa parentesi, allenare il pensiero computazionale può essere utile qualsiasi professionista per migliorare l’approccio comunicativo nei contesti lavorativi e farsi capire con efficacia.