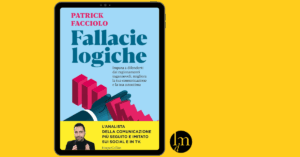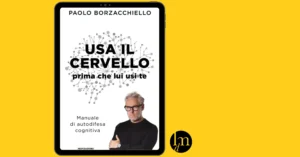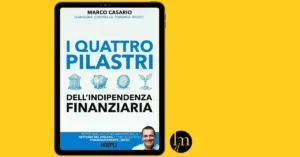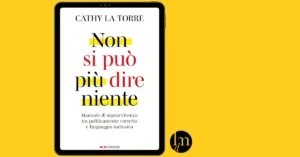Il conduttore televisivo, nonché giornalista e vincitore di un Emmy Award, Chris Hayes, con Il canto delle sirene offre un’analisi acuta e disincantata del radicale cambio di paradigma, che ha trasformato l’attenzione nella risorsa più cruciale del XXI secolo. La sua tesi fondamentale è che, proprio come il lavoro fu mercificato nell’Ottocento, oggi l’attenzione è diventata una merce fittizia da estrarre, che richiede di scassinare le nostre menti e che ha abbattuto il confine tra sfera pubblica e privata in meno di un decennio.
Il libro viene visto come una via per riprendersi la mente, che racchiude un monito necessario. Un testo indispensabile per chi cerca di capire come le nostre strutture neurologiche più profonde si trovino in un habitat progettato per predarle.
Il focus, quindi, è l’attenzione come bisogno fondamentale e spesso come motivazione di sopravvivenza, nonostante il suo mantenimento risulti sempre più difficile in una società che ci sovrastimola continuamente, sia attraverso i dispositivi elettronici, sia tramite la frenesia che caratterizza la vita di ciascuno di noi.
L’autore riconduce metaforicamente il richiamo all’attenzione dalla figura della sirena di un allarme, alla figura mitologica della sirena ritrovata nell’Odissea. Che si tratti della sirena di un’ambulanza o della tentazione che vuole spingere Ulisse in mare, la sirena resta un’immagine universale, concepita per attirare la nostra attenzione, la cui somma di attimi compone la nostra intera esistenza.
La slot machine tascabile: l’architettura della cattura
A oggi, catturare l’attenzione di qualcuno o di un gruppo di individui non sembra una sfida particolarmente ardua, ma mantenerla pone dei problemi più frequenti. Una delle soluzioni più accettabili sembra essere proprio quella di attirarla di continuo, come dimostra il meccanismo delle slot-machine, composto da una giocata intensa di pochi secondi e un richiamo dell’attenzione attraverso luci intense, in attesa della regolazione dell’esito, proponendo così uno schema standard e ripetitivo
Hayes articola il concetto di attenzione in tre aspetti — volontaria, involontaria e sociale — per svelare l’asimmetria sfruttata dai giganti del tech: è più facile attrarre l’attenzione che mantenerla. Le app di social media, da Facebook a TikTok, agiscono come vere e proprie “slot machine tascabili”, mantenendo il fruitore attraverso una serie incessante di interruzioni e nuovi stimoli. La loro efficacia risiede nel monetizzare l’attenzione sociale, sfruttando il bisogno primordiale di essere notati tramite notifiche e menzioni, un meccanismo che l’ex dipendente di Google Tristan Harris definisce come una orchestrazione dell’approvazione sociale.
Il paradosso del re e l’alienazione del sé
Questa costante estrazione neurologica provoca un senso diffuso di alienazione. Riallacciandosi alla filosofia, Hayes richiama il principio di Herbert Simon (1971): “l’abbondanza dell’informazione comporta la scarsità dell’attenzione dei suoi fruitori”. L’eccesso di dati genera carenza di attenzione. Parallelamente, l’autore esplora il “paradosso del re” (il desiderio insaziabile di svago dovuto all’incapacità di sopportare la noia) e la distinzione di Søren Kierkegaard (1843), per cui la noia è “la radice di ogni male”. La soluzione non è l’aumento degli stimoli, ma la ricerca del flow (concentrazione ottimale) e l’orientamento intenzionale della mente.
La guerra per l’attenzione nel discorso pubblico
Nell’arena pubblica, l’attenzione non è più un mezzo per la persuasione, ma un fine in sé. La politica si trasforma in una guerra per l’attenzione di tutti contro tutti. Figure come Donald Trump sono i massimi interpreti di questo nuovo regime attenzionale, capaci di barattare la simpatia con la salienza, ricercando anche l’attenzione negativa. Tattiche come il “trolling” e il “benaltrismo” (o whataboutism) sono le armi perfette per massimizzare l’engagement in un ecosistema mediatico iper-competitivo, dove una “grande bugia tende a essere più efficace di un insieme di piccole verità”.

L’autore invita i lettori a intraprendere un percorso per riprenderci la nostra mente e tornare a scegliere a cosa prestare davvero attenzione, attuando meccanismi di impegno consapevole, come il ritorno a forme di consumo mediale che richiedono attenzione volontaria. L’ultima frontiera è la regolamentazione e la creazione di spazi sociali non commerciali.
Il libro si rivolge a un pubblico vasto: in particolare a genitori e istituzioni scolastiche preoccupati per la generazione ansiosa; ai professionisti del marketing e dei media che desiderano comprendere la vera fonte del potere digitale; e, soprattutto, e a chiunque si senta intrappolato in questo “tapis roulant attentivo” e voglia resistere all’alienazione per ricostruire una vita interiore basata sulla scelta.