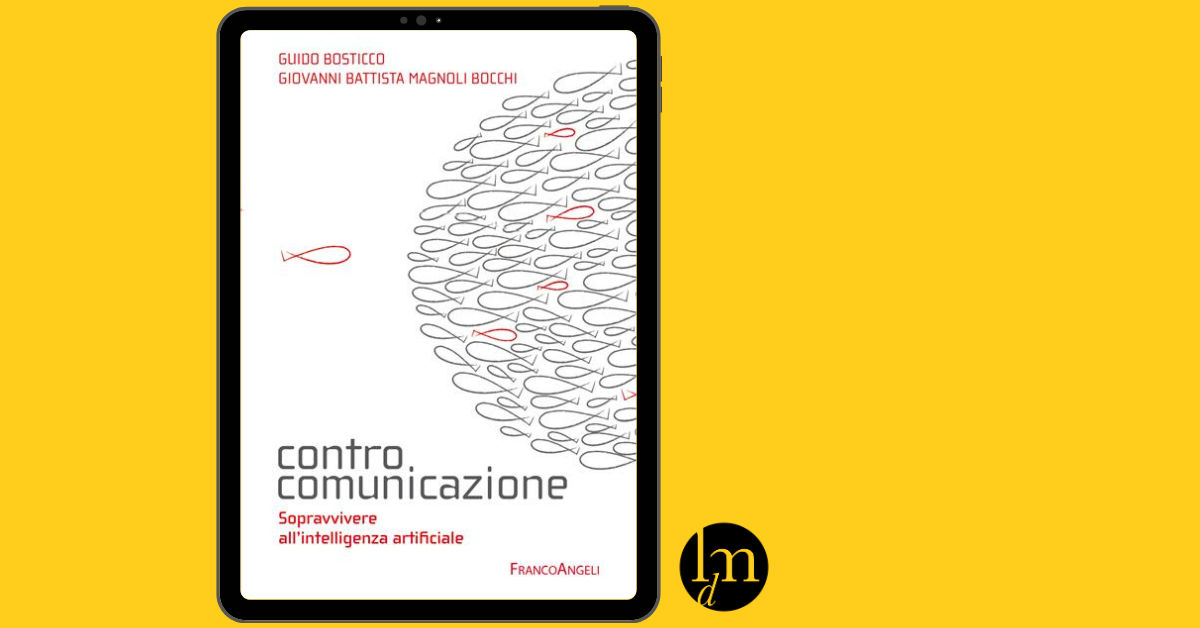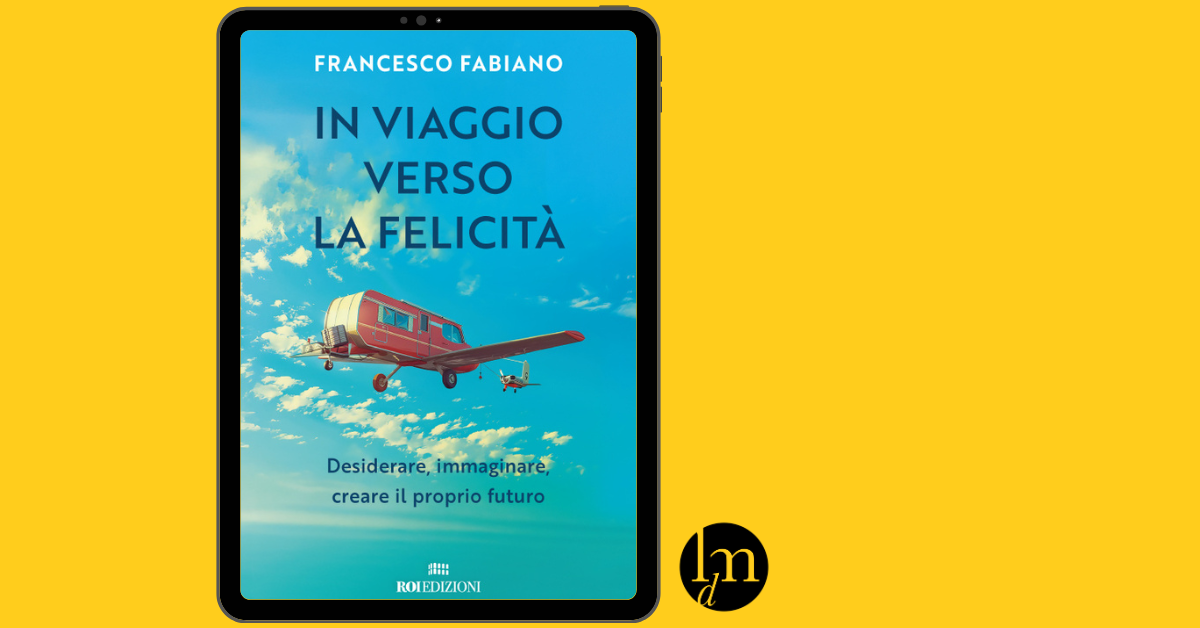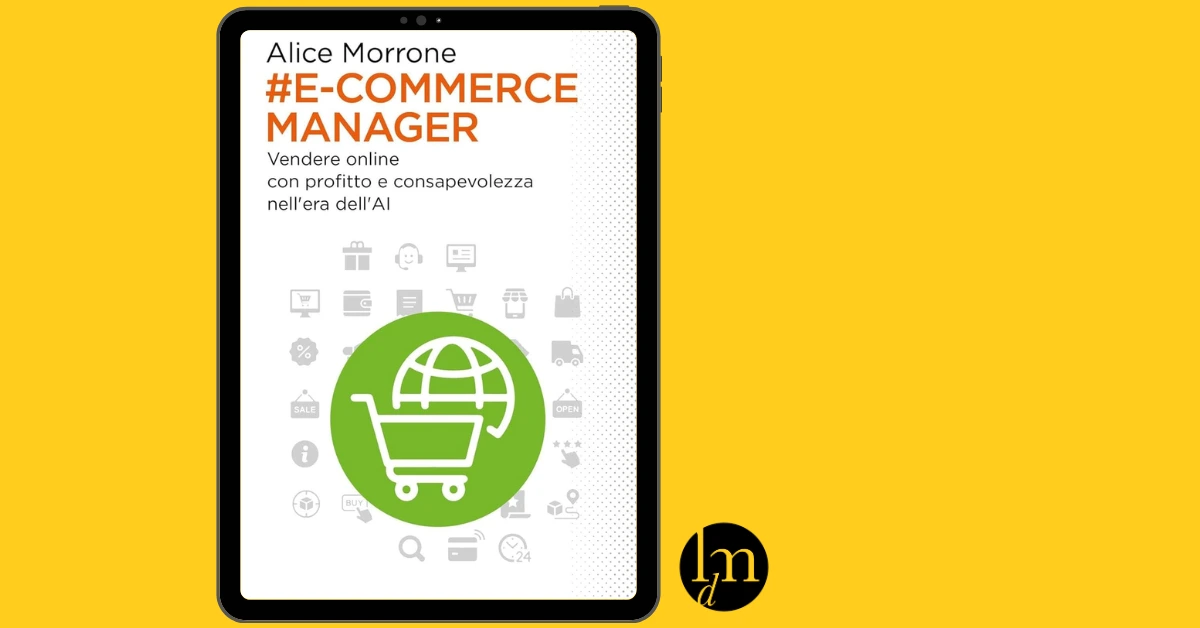La comunicazione è un’arte, ma anche una responsabilità. Lo sa bene Vera Gheno, sociolinguista, divulgatrice e voce autorevole nel panorama italiano, che da anni esplora l’evoluzione della lingua italiana e il suo impatto sociale.
Autrice di saggi come Potere alle parole e Le ragioni del dubbio, Vera Gheno indaga da anni come le parole possano costruire ponti o innalzare barriere, influenzando il modo in cui percepiamo noi stessi e il mondo che ci circonda.
Il 19 giugno sarà tra i protagonisti del Public Speaking & Storytelling Forum di Performance Strategies a Milano. Qui condividerà la sua visione su come la scelta del linguaggio possa diventare uno strumento strategico e inclusivo, capace di ispirare e coinvolgere diversi pubblici, dalle aziende ai singoli individui.
In questa intervista, esploreremo con lei il potere nascosto dietro ogni parola, le sfide del linguaggio inclusivo e come brand e imprese possano evitare scivoloni comunicativi, rendendo il proprio messaggio autentico e rispettoso della diversità.
Le sfide del linguaggio inclusivo e le strategie di marketing delle aziende
Durante l’evento di Performance Strategies parlerai del potere delle parole. Per costruire un legame profondo con il pubblico, il brand deve saper raccontare una storia avvincente. Quali sono, secondo te, i tre ingredienti essenziali per uno storytelling aziendale efficace, che riesca a toccare corde emotive e rimanere impresso nel tempo, mantenendo una comunicazione strategica, efficace ed etica?
Premesso che l’essere umano è un animale narrante e narrato, nel senso che non può non comunicare, penso che alla base di una buona comunicazione ci sia quella che Herbert Grice chiamava truthfulness, concetto tradotto tradizionalmente come “sincerità”. E si può essere sinceri e sincere quando si è competenti di quello di cui si parla o si scrive, ma si crede anche nella validità del messaggio che si va a comunicare. Se si dice una cosa senza una vera convinzione, si sente. Secondariamente, penso che ci sia bisogno di una certa armonia tra ciò che accade all’interno dell’azienda e ciò che si pretende di comunicare verso l’esterno. In terzo luogo, serve equilibrio tra forma e sostanza. Solo forma e solo sostanza non sono ottimali.
Possiamo dire che le parole possono diventare strumenti di inclusione o armi di divisione. Molte aziende stanno integrando la comunicazione inclusiva nelle loro strategie di marketing. Quali strategie possiamo mettere in atto per rendere il linguaggio un veicolo di parità e non di esclusione e quali errori comuni riscontri quando brand e imprese affrontano il tema del linguaggio inclusivo?
C’è, alla base, un errore di prospettiva, secondo me: l’idea che il linguaggio inclusivo, o meglio ampio, come preferisco chiamarlo io, sia un insieme di regole da mandare a memoria e in base alle quali “depurare” qualsiasi messaggio. Il linguaggio ampio non è un set di norme, ma una prospettiva: l’idea che, per riuscire a fare una comunicazione davvero attenta alla varietà umana, tale varietà vada ascoltata. Insomma, se si continua ad avere l’idea che l’inclusione sia una lista di attenzione verso i “diversi”, sarà sempre un contentino dato alle minoranze marginalizzate. Bisogna puntare, come dice Fabrizio Acanfora, alla convivenza delle differenze, che è oltre l’inclusione. Il riconoscimento della varietà umana come componente naturale dell’umanità, non come un accollo da sistemare.
I social media sono spazi aperti, dove ogni brand riceve critiche, suggerimenti e discussioni pubbliche. Come possiamo trasformare i feedback negativi in opportunità comunicative e gestire le conversazioni online in modo costruttivo, mantenendo la reputazione del brand e conquistando anche nuovi pubblici?
Bella domanda. Non so rispondere, ma i miei trent’anni online mi hanno insegnato una cosa: intanto, che a volte non basta tutto l’impegno del mondo per farsi capire come si intendeva (perché ogni atto comunicativo è cooperativo: serve che sia mittenti sia destinatari cooperino per capirsi); secondariamente, che c’è una quota di persone alle quali non si arriverà mai, perché non vuole ascoltarci. Forse, sia a livello aziendale, sia a livello individuale, può essere utile capire quando un feedback negativo può servire per qualche scopo costruttivo e quando invece è una mera perdita di tempo perché generata da frustrazione, disagio, a volte perfino cattiveria, o magari voglia di “trollare”. Io una volta pensavo che fosse corretto rispondere a ogni persona; poi, ho capito che cercare di argomentare con chi non ne vuole sapere è davvero un modo poco produttivo di impegnare il proprio tempo.